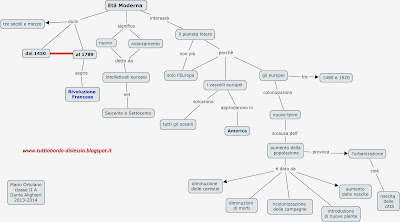Lo staff di iPMI.it segnala la pubblicazione del Focus BNL n. 16 del 7 maggio 2013 (download .pdf), il settimanale del Servizio Studi BNL, che fa il punto sulla congiuntura economica in Italia.
Abstract:
«Nel mese di marzo il numero dei disoccupati sale a 3 milioni in Italia e a 3,3 milioni in Francia mentre scende a 2,3 milioni in Germania. Via via la piaga della disoccupazione si estende e potrebbe in futuro interessare anche la Germania come già indicano le significative flessioni al momento registrate dalle esportazioni tedesche verso i paesi dell’area euro. Oltre al contenimento dei deficit pubblici, cresce la pressione per una maggiore attenzione delle politiche europee verso il problema del deficit di lavoro.
Lo sport in Italia ha assunto una dimensione economica rilevante: nel 2011 il peso sul Pil è stato pari all’1,6% con un giro d’affari di circa 25 miliardi di euro.
Le spese per lo sport delle famiglie italiane ammontano a 22 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale dei consumi. In Italia circa una persona su tre pratica un’attività sportiva. Nell’ultimo decennio si sono registrati significativi progressi in termini di tasso di partecipazione. Il numero di persone che praticano sport è aumentato di 2,7 punti percentuali (pari a circa 1,6 milioni), a fronte di una contrazione di 1,2 milioni nel numero dei sedentari. L’Italia registra una spesa pubblica destinata allo sport inferiore in valore assoluto rispetto a molti paesi, i risultati olimpici ottenuti dallo sport italiano anche recentemente restano comunque di livello elevato.
Editoriale: Oltre la soglia
I numeri parlano. In marzo il numero totale dei disoccupati è salito a tre milioni in Italia e a 3,3 milioni in Francia. I senza lavoro superano i venticinque milioni nel complesso dell’Unione europea e lambiscono i venti entro il perimetro più circoscritto dell’area dell’euro. Insieme ai disoccupati propriamente detti aumentano le dimensioni di aree contigue di grave disagio sociale. Sommando ai disoccupati gli inattivi disponibili a lavorare, quelli che cercano lavoro e i sotto-occupati part-time i numeri del deficit europeo di occupazione passano da venticinque a quarantacinque milioni di persone.
Si tratta di quasi il venti per cento dell’intera forza lavoro presente nell’unione a 27 paesi. Nella sola area dell’euro questa condizione allargata di disoccupazione caratterizza ben 32 milioni di individui: per intendersi, due volte la popolazione dei Paesi Bassi o poco più della metà di quella francese o italiana.
I numeri europei della crescente disoccupazione parlano chiaro. Mese dopo mese le cifre diffuse dall’Eurostat reiterano la gravità di un problema fondamentale che è economico, sociale ed anche civile, nell’accezione di un’Europa intesa come luogo di democrazia e di sviluppo. I ritardi che si rilevano nell’attivazione di un’adeguata risposta europea alla sfida lanciata dalla disoccupazione fanno riflettere e suscitano interrogativi. Perché questa relativa sensibilità al tema del lavoro? Verosimilmente, per due ordini di motivi.
Il primo motivo è più economico che politico. È un problema di divergenza. Mentre nel suo insieme in Europa la disoccupazione cresce, in Germania la disoccupazione invece diminuisce a minimi storici mai visti negli ultimi venti anni. Oggi in Germania i disoccupati sono poco più di due milioni, la terza parte della somma di Italia e Francia e la metà di quelli che l’economia tedesca accusava prima della crisi. È questa oggettiva divergenza tra Germania e resto d’Europa che rende il dialogo più difficile. Ma è una divergenza transitoria, poiché prima o poi il dilagare della disoccupazione nel resto d’Europa si rifletterà negativamente anche sul mercato tedesco del lavoro. Il batterio di una convergenza al ribasso è già in azione e si ravvisa nella flessione di tre punti percentuali che le esportazioni verso l’area euro della Germania hanno segnato nei dodici mesi terminanti a febbraio 2013.
Il secondo motivo dietro la poca attenzione europea al tema della disoccupazione è più politico che economico. Gli obiettivi di politica economica che persegue l’area dell’euro rimangono incardinati su un modello che, pur aggiornato e variamente arricchito, ancora riflette una matrice precisa. Quella del Trattato firmato ventuno anni fa a Maastricht, in un mondo ove la globalizzazione delle manifatture non si conosceva e il nemico da battere non era la disoccupazione, bensì l’inflazione e i rischi inflazionistici prodotti da valute nazionali e da finanze pubbliche fuori controllo. In quel contesto fu decisa la soglia del tre per cento del rapporto tra deficit pubblico e PIL che ancora oggi rappresenta un faro del modello europeo di politica economica. Nel 1992 la scelta del tre per cento cadde sul valore che l’anno prima era stato assunto dal rapporto tra deficit pubblico e PIL della Germania. Verosimilmente non fu un caso, ma il razionale riferimento al paese che nel corso degli anni Ottanta meglio di altri aveva fatto sul fronte del controllo dell’inflazione e dei conti pubblici.
Oggi che il problema europeo numero uno è il lavoro sarebbe forse il caso di arricchire la carta fondamentale della comune politica economica con un più forte baricentro sulla promozione della crescita e sulla riduzione della disoccupazione. Nelle pieghe della “Macroeconomic Imbalance Procedure” prevista dal “Six Pack” europeo approvato alla fine del 2011 si legge di una soglia indicativa del dieci per cento da non superare per i tassi di disoccupazione dei paesi membri dell’Unione. È un riferimento importante, che però si perde entro circa una dozzina di indicatori di potenziale squilibrio macroeconomico, dalle quote di mercato all’export alla variazione dei prezzi degli immobili. Non basta. A marzo 2008 i paesi dell’eurozona con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al venti percento erano solo tre. Oggi sono dieci e contano per i due terzi dei 330 milioni di abitanti dell’unione monetaria. È in questo contesto che le regole della politica europea dovrebbero dare alla crescita del lavoro una dignità prioritaria, non inferiore a quella attribuita al contenimento dei deficit pubblici. Oltre alle procedure nazionali per deficit eccessivi, l’Europa potrebbe prevedere una procedura comune per disoccupazione eccessiva. Un cantiere da aprire insieme e portare avanti nell’interesse e con l’impegno lungimirante di tutti, nessuno escluso».
Lo sport in Italia ha assunto una dimensione economica rilevante: nel 2011 il peso sul Pil è stato pari all’1,6% con un giro d’affari di circa 25 miliardi di euro.
Le spese per lo sport delle famiglie italiane ammontano a 22 miliardi di euro, pari al 2,3% del totale dei consumi. In Italia circa una persona su tre pratica un’attività sportiva. Nell’ultimo decennio si sono registrati significativi progressi in termini di tasso di partecipazione. Il numero di persone che praticano sport è aumentato di 2,7 punti percentuali (pari a circa 1,6 milioni), a fronte di una contrazione di 1,2 milioni nel numero dei sedentari. L’Italia registra una spesa pubblica destinata allo sport inferiore in valore assoluto rispetto a molti paesi, i risultati olimpici ottenuti dallo sport italiano anche recentemente restano comunque di livello elevato.
Editoriale: Oltre la soglia
I numeri parlano. In marzo il numero totale dei disoccupati è salito a tre milioni in Italia e a 3,3 milioni in Francia. I senza lavoro superano i venticinque milioni nel complesso dell’Unione europea e lambiscono i venti entro il perimetro più circoscritto dell’area dell’euro. Insieme ai disoccupati propriamente detti aumentano le dimensioni di aree contigue di grave disagio sociale. Sommando ai disoccupati gli inattivi disponibili a lavorare, quelli che cercano lavoro e i sotto-occupati part-time i numeri del deficit europeo di occupazione passano da venticinque a quarantacinque milioni di persone.
Si tratta di quasi il venti per cento dell’intera forza lavoro presente nell’unione a 27 paesi. Nella sola area dell’euro questa condizione allargata di disoccupazione caratterizza ben 32 milioni di individui: per intendersi, due volte la popolazione dei Paesi Bassi o poco più della metà di quella francese o italiana.
I numeri europei della crescente disoccupazione parlano chiaro. Mese dopo mese le cifre diffuse dall’Eurostat reiterano la gravità di un problema fondamentale che è economico, sociale ed anche civile, nell’accezione di un’Europa intesa come luogo di democrazia e di sviluppo. I ritardi che si rilevano nell’attivazione di un’adeguata risposta europea alla sfida lanciata dalla disoccupazione fanno riflettere e suscitano interrogativi. Perché questa relativa sensibilità al tema del lavoro? Verosimilmente, per due ordini di motivi.
Il primo motivo è più economico che politico. È un problema di divergenza. Mentre nel suo insieme in Europa la disoccupazione cresce, in Germania la disoccupazione invece diminuisce a minimi storici mai visti negli ultimi venti anni. Oggi in Germania i disoccupati sono poco più di due milioni, la terza parte della somma di Italia e Francia e la metà di quelli che l’economia tedesca accusava prima della crisi. È questa oggettiva divergenza tra Germania e resto d’Europa che rende il dialogo più difficile. Ma è una divergenza transitoria, poiché prima o poi il dilagare della disoccupazione nel resto d’Europa si rifletterà negativamente anche sul mercato tedesco del lavoro. Il batterio di una convergenza al ribasso è già in azione e si ravvisa nella flessione di tre punti percentuali che le esportazioni verso l’area euro della Germania hanno segnato nei dodici mesi terminanti a febbraio 2013.
Il secondo motivo dietro la poca attenzione europea al tema della disoccupazione è più politico che economico. Gli obiettivi di politica economica che persegue l’area dell’euro rimangono incardinati su un modello che, pur aggiornato e variamente arricchito, ancora riflette una matrice precisa. Quella del Trattato firmato ventuno anni fa a Maastricht, in un mondo ove la globalizzazione delle manifatture non si conosceva e il nemico da battere non era la disoccupazione, bensì l’inflazione e i rischi inflazionistici prodotti da valute nazionali e da finanze pubbliche fuori controllo. In quel contesto fu decisa la soglia del tre per cento del rapporto tra deficit pubblico e PIL che ancora oggi rappresenta un faro del modello europeo di politica economica. Nel 1992 la scelta del tre per cento cadde sul valore che l’anno prima era stato assunto dal rapporto tra deficit pubblico e PIL della Germania. Verosimilmente non fu un caso, ma il razionale riferimento al paese che nel corso degli anni Ottanta meglio di altri aveva fatto sul fronte del controllo dell’inflazione e dei conti pubblici.
Oggi che il problema europeo numero uno è il lavoro sarebbe forse il caso di arricchire la carta fondamentale della comune politica economica con un più forte baricentro sulla promozione della crescita e sulla riduzione della disoccupazione. Nelle pieghe della “Macroeconomic Imbalance Procedure” prevista dal “Six Pack” europeo approvato alla fine del 2011 si legge di una soglia indicativa del dieci per cento da non superare per i tassi di disoccupazione dei paesi membri dell’Unione. È un riferimento importante, che però si perde entro circa una dozzina di indicatori di potenziale squilibrio macroeconomico, dalle quote di mercato all’export alla variazione dei prezzi degli immobili. Non basta. A marzo 2008 i paesi dell’eurozona con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al venti percento erano solo tre. Oggi sono dieci e contano per i due terzi dei 330 milioni di abitanti dell’unione monetaria. È in questo contesto che le regole della politica europea dovrebbero dare alla crescita del lavoro una dignità prioritaria, non inferiore a quella attribuita al contenimento dei deficit pubblici. Oltre alle procedure nazionali per deficit eccessivi, l’Europa potrebbe prevedere una procedura comune per disoccupazione eccessiva. Un cantiere da aprire insieme e portare avanti nell’interesse e con l’impegno lungimirante di tutti, nessuno escluso».